Pinocchio non è perbene
Pinocchio non è perbene
25 settembre 2016
«E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto? — Eccolo là — rispose Geppetto: e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato sur una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo; e dopo che l’ebbe guardato un poco, disse dentro di sé con grandissima compiacenza: — Com’ero buffo, quand’ero un burattino! e come ora son contento di esser diventato un ragazzino perbene!...».
Chi non ha provato un moto di delusione alla lettura di questo passo finale delle Avventure di Pinocchio? Delusione dopo la «meraviglia» condivisa con il protagonista per la metamorfosi in ragazzo, in «una bella camerina ammobiliata»; per l’immancabile commento degli adulti pronti ad accentuare un altro passo di quell’ultimo capitolo (il XXXVI) del capolavoro collodiano:
« — Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo — disse Geppetto. […] — Perché quando i ragazzi, di cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all’interno delle loro famiglie».
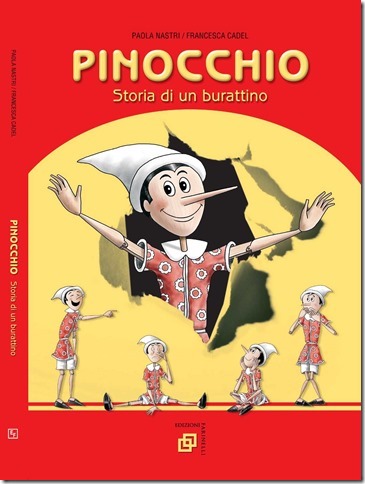 Ma bisogna essere buoni come? Ubbidienti agli adulti, immemori di sé per non turbarne il riposo o lo svago, aumentarne i pensieri, inciamparne i programmi: adulti appunto, in una bilancia tutt’altro che in equilibrio.
Ma bisogna essere buoni come? Ubbidienti agli adulti, immemori di sé per non turbarne il riposo o lo svago, aumentarne i pensieri, inciamparne i programmi: adulti appunto, in una bilancia tutt’altro che in equilibrio.
Pinocchio è invece il bambino che vuol fare esperienza della vita in libertà, con i rischi che ne derivano. Con le sue bugie di bimbo è l’emblema della vitalità e dello splendore dell’infanzia autonoma eppure bisognosa di cura: tutti vi si possono riconoscere. Il burattino/ciuchino/bambino incontra il male, la morte, ma vive anche la rinascita; trova amici veri; incappa nella giustizia ingiusta; conosce falsità e furberia, generosità e dabbenaggine; e la fame, la durezza del lavoro e il riscatto che esso offre. Ha in Geppetto un padre premuroso come una madre, nella Fata dai capelli turchini una madre ferma come un padre. È allora credibile che un romanzo ricco di tante aperture nuove e di straordinario estro comico-umoristico si concluda come una qualsiasi opera edificante di quell’Ottocento un po’ polveroso, e autoritario senza “un po’”?
Con un «bel vestiario nuovo […] un pajo di stivaletti di pelle, che gli tornavano una vera pittura», Pinocchio dice «Com’ero buffo, quand’ero un burattino! e come ora son contento di esser diventato un ragazzino perbene!...», solo «dentro di sé», non a voce alta. E «con grandissima compiacenza» aggiunge Collodi, che non scrive mai a caso. «Compiacenza» implica il compiacimento indulgente, ma pure la degnazione paternalistica: colloquialmente, “il guardare dall’alto in basso”. Unita al superlativo assoluto «grandissima», la parola fa emergere il pensiero di Collodi nei confronti di Pinocchio: quel degnarsi del ragazzo verso il «grosso» burattino di legno «con le braccia ciondoloni» è solo vanagloria, un bel po’ di presunzione. Il punto esclamativo, poi, indica l’enfasi della sorpresa. Pinocchio infine conosce e si riconosce: perciò sorride di sé burattino, tanto se ne sente diverso e superiore. Collodi, però, gli fa un brutto tiro, aggiungendo al punto esclamativo i tre puntini di sospensione: punto “ammirativo” e puntini canonici, quando questo Autore vuol satireggiare i personaggi di cui scrive. I tre puntini inseriscono una pausa nel discorso lasciandolo aperto, suggerendo una titubanza: un accenno vago e, per l’esattezza, sospeso. È la reticenza, che non dice e dice, lascia intendere il seguito ma non lo esplicita: fa completare l’enunciato al lettore con una strizzatina d’occhio complice, come sempre avviene nella scrittura umoristica, in cui l’Autore interviene a sottolineare passaggi, a richiamare l’attenzione, a commentare episodi, ma anche a far saltare le convenzioni. Il Pinocchio che ride di sé un tempo burattino irriverente, ingenuo ma di buon cuore, diventerà un adulto di quelli con cui Collodi ha a che fare ogni giorno e che schernisce nelle sue opere per i grandi: pièces teatrali come Gli Amici di casa (1856), il romanzo I Misteri di Firenze (1857-1858), Macchiette (1880; II ediz. 1884), Occhi e nasi (1881). Collodi sbeffeggia gli adulti vanesi e paghi di sé, uomini e donne che, a ogni costo, vanno in caccia di privilegi, di ricchezza, di lusso e di sesso, oppure inseguono il potere politico; che mentono e ingannano, trafficano in maniera losca pur di raggiungere i propri scopi meschini.
 Pinocchio si apre nel segno ironico e satirico di un pezzo di legno che parla, ride, corre, sente, mangia e dorme come un bambino; procede nel vortice di vicende mirabolanti piene di buffi ribaltamenti, trovate umoristiche che mettono alla berlina la società (adulta) del suo tempo; per chiudersi nello stesso segno, con uno sberleffo ancora più sferzante: l’irrisione del ragazzino - che quel Pinocchio è diventato - vanerello e compiaciuto di sé. La simmetria è perfetta: altro che un capolavoro scritto per caso e nato dal nulla, come si è detto e ripetuto; o un’opera costretta a indossare una camicia di forza pedagogica, tradendo in parte la propria coerenza formale e la portata trasgressiva. Il burattino è perciò tutt’altro che morto; semmai è stata pronta a ucciderlo una cultura timorosa dell’indipendenza e della bellezza avventurosa dell’infanzia e della conoscenza.
Pinocchio si apre nel segno ironico e satirico di un pezzo di legno che parla, ride, corre, sente, mangia e dorme come un bambino; procede nel vortice di vicende mirabolanti piene di buffi ribaltamenti, trovate umoristiche che mettono alla berlina la società (adulta) del suo tempo; per chiudersi nello stesso segno, con uno sberleffo ancora più sferzante: l’irrisione del ragazzino - che quel Pinocchio è diventato - vanerello e compiaciuto di sé. La simmetria è perfetta: altro che un capolavoro scritto per caso e nato dal nulla, come si è detto e ripetuto; o un’opera costretta a indossare una camicia di forza pedagogica, tradendo in parte la propria coerenza formale e la portata trasgressiva. Il burattino è perciò tutt’altro che morto; semmai è stata pronta a ucciderlo una cultura timorosa dell’indipendenza e della bellezza avventurosa dell’infanzia e della conoscenza.
Pinocchio non dovrà allora diventare “perbene”. Forse è vero l’aneddoto riferito da Ermenegildo Pistelli che muoveva critiche alla conclusione delle Avventure, alle quali Collodi avrebbe risposto: «Sarà, ma io non ho memoria d’aver finito a questo modo»


